Dalla supremazia del terroir al terroir utopia
di Nicola CeredaDe Bello Gallico, Libro Secondo: Giulio Cesare descrive l’assedio agli Atuatuci rifugiatisi all’interno della loro roccaforte: “Quando videro che, avanzate le vinee e innalzato il terrapieno, si stava costruendo lontano una torre, subito, dall’alto delle mura, cominciarono a deriderci e a schernirci domandando perché mai stessimo costruendo a tanta distanza un macchinario così imponente: con quali mani e con quali forze degli ometti così piccoli – per i Galli infatti, in generale, la nostra statura, piccola rispetto all’imponenza dei loro corpi, è oggetto di disprezzo – credevano di poter avvicinare al muro una torre così pesante?”
E’ il 58 a.c. e credo si tratti del primo documento storico che ci restituisce in un colpo solo gli aspetti antropologici, sociologici e psicologici che sfoceranno nella rivalità tra francesi e italiani mettendo in risalto l’alterigia dei primi e l’implicito senso d’inferiorità dei secondi. Degli Atuatuci, sterminati dall’esercito romano (assieme ad altri 2 milioni di persone), resta solo questa traccia grazie alla magnanimità di Cesare nello stilare i suoi commentarii perché, come è noto, la storia è scritta dai vincitori.
E i francesi ci rispettano
Che le balle ancora gli girano
E tu mi fai, dobbiamo andare al cine
E vai al cine, vacci tu!
In un certo senso la conquista della Gallia è anche l’affermazione della civiltà mediterranea del pane, dell’olio e del vino, sui ‘barbari’ dediti a caccia e pastorizia, la cui alimentazione era costituita sostanzialmente da carne e latte. Piantare grano, olivi, vigne per ricavarne pane, olio e vino presupponeva essere in possesso di conoscenze complesse, di storia, di cultura e di una spinta all’innovazione tecnologica indispensabili per lo sfruttamento e la trasformazione delle risorse naturali. Scrive Massimo Montanari in Gusti del Medioevo: “Quei prodotti […] diventarono il veicolo di un’ideologia che rappresentava la civiltà appunto come capacità di inventare la propria vita e di plasmare la natura – vino, pane, olio in natura non esistono. E’ in questa duplice prospettiva, materiale e mentale, che il vino assume il ruolo di indicatore, marker (si direbbe in linguaggio sociologico) della romanità”. Del resto pare che i romani, tra le altre cose, si affrettassero a piantare vigne nelle nuove province per certificare l’intenzione di rimanerci stabilmente con un progetto a lungo termine.
COMUNICAZIONE E DENOMINAZIONE DI ORIGINE
Eppure è proprio la progenie di quelle popolazioni galliche, oggetto della pulizia etnica e della pax romana, ad eccellere e distinguersi sul pianeta, duemila anni più tardi, per l’alta qualità della produzione vitivinicola. Per taluni, questo sarebbe dovuto al fatto che, in quanto a efficacia nella comunicazione, gli eredi di Asterix non avrebbero rivali. Ad esempio possiedono il monopolio sui termini usati per indicare il concetto di origine; vocaboli che viaggiano paralleli e complementari alle denominazioni (le 450 Appellations d’Origine contrôlées) e che non trovano adeguata corrispondenza nella lingua di Dante: terroir, climat, cru, clos (o enclos), lieu-dit… Dalla nostra abbiamo parole come podere, vigna, parcella, bric o sorì, talvolta riportate in etichetta senza che si accenda alcuna luce per il potenziale acquirente. Sono soprattutto terroir e cru i francesismi che fanno ormai stabilmente parte del nostro vocabolario, in quanto particolarmente eloquenti e privi di una traduzione efficace. A volte mi domando se anche questo aspetto linguistico non rientri nel contesto di una globale sindrome di inferiorità dalla quale non ci si riesce ad affrancare se non per brevissimi periodi e più che altro per vicende di carattere sportivo. Del resto insistiamo a chiamarli cugini senza essere mai ricambiati. Strano tipo di parentela.
Tra i francesi che s’incazzano
E i giornali che svolazzano
E tu mi fai, dobbiamo andare al cine
E vai al cine, vacci tu!
TERROIR
Dal dizionario Treccani: “Nel linguaggio enogastronomico, termine indicante il rapporto che lega un prodotto (vino, caffè, ecc.) alle caratteristiche del microclima e del suolo in cui è coltivato”.
Sandro Sangiorgi spiega più precisamente in una sezione dell’originale Il vino capovolto: (il terroir) “è la congiunzione di specifiche condizioni di una zona, o in un suo particolare vigneto, tra il luogo (inteso come combinazione di suolo, sottosuolo, e clima) e le consuetudini artigianali, così radicate da divenire ‘territoriali’, quali la potatura, il metodo di raccolta, i processi di vinificazione e la maturazione in particolari recipienti”.
Non solo geologia e clima, quindi, ma testimonianza della relazione sempiterna tra uomo e natura che si declina in maniera differente per mille e una variabile. Angiolino Maule presidente di VinNatur: “il cervello della pianta è nella radice e la radice è nella terra. L’uomo, che è parte della natura stessa, può essere co-creatore o co-distruttore di suolo”. Émile Peynaud sosteneva ne Il gusto del vino che: “non esiste un grande vino senza un grande terroir. Il clima, il sole ed il vitigno sono i fattori naturali della qualità ma essi hanno bisogno, per un’adeguata valorizzazione, dei fattori umani e del lavoro umano”. Gli fa eco Jacky Rigaux, docente presso l’Université de Bourgogne: “senza il talento dell’uomo, il più grande terroir resta solo una speranza”. Poco importa se la manodopera specializzata in vigna sia in parte alloctona e talvolta proveniente da paesi e culture ben lontani dal pianeta vino, almeno così come lo intendiamo noi.
Ma il terroir è davvero riconoscibile nel bicchiere? Jacky Rigaux ne è fermamente convinto, come spiega nel suo breve trattato dal titolo La degustazione geosensoriale. Affinchè questo accada è preferibile che le viti siano a piede franco e che la fermentazione sia condotta dai lieviti indigeni, in quanto strumenti di elezione per trasferire al vino i caratteri ipogeo ed epigeo del luogo nella maniera più fedele. “Intervenire il meno possibile durante la vinificazione […] è così che il terroir si rivela. Tutti gli interventi intempestivi o eccessivi da parte dell’uomo sul mosto che si sta trasformando in vino non fanno che disturbare l’impronta del luogo”. Rigaux invoca un ritorno ad un approccio alla degustazione differente rispetto ai canoni oggi in uso. ”La degustazione geosensoriale s’interessa ai luoghi di nascita del vino, ai diversi minerali presenti nei terreni […] e pone l’accento sull’aspetto tattile e sulla sapidità, senza ignorare gli aromi, colti soprattutto nel retro-olfatto […] La mineralità di tutti i grandi vini di terroir si apprezza attraverso il gusto, attraverso la sensazione di sapidità e di salinità che ogni grande vino di terroir rileva naturalmente”.
CRU E CLIMAT
Nella stessa Francia, il significato di cru tende ad assumere sfumature differenti a seconda del contesto e della regione: può indicare tanto un singolo vigneto quanto un intero villaggio. Esemplare la definizione data a suo tempo da Luigi Veronelli: “si dice cru una località o una vigna di particolare pregio, all’interno di una zona viticola già di grande prestigio”. Una mattonella in grado di dare origine a un vino con caratteristiche uniche ed irripetibili per via di peculiarità di tipo geologico, geografico, microclimatico, storico, antropologico e ampelografico. Il concetto di cru si afferma definitivamente nel 1855 con la prima classificazione dei vini di Bordeaux operata per volere di Napoleone III sulla base del gradimento del mercato inglese, principale acquirente e consumatore. Classificazione che, incredibilmente, resiste ancora oggi. I cru maggiormente vocati di Bordeaux sono quelli per i quali, quasi duecento anni fa, i mercanti d’oltremanica erano disposti a pagare di più. Riusciamo ad immaginare, nell’era dei big-data, la fotografia che ne uscirebbe dell’Italia vitivinicola, se si reinventassero le zonazioni sulla base del prezzo medio che ogni bottiglia stacca nel mercato globale? Il climat, vocabolo ben più antico, è il corrispettivo borgognone di cru e giunge fino a noi grazie al meticoloso lavoro di catalogazione delle parcelle iniziato dai monaci benedettini e cistercensi più di mille anni fa. Aubert de Villaine, comproprietario di Domaine de la Romanée-Conti afferma che “il climat non è un’entità rigida ma un progetto congiunto dell’uomo e della natura, in costante evoluzione, vulnerabile, immateriale sotto molti aspetti, che bisogna difendere quotidianamente”. Non è mia intenzione buttarla in caciara ma è indubbio che specializzarsi nel riconoscimento tra climat di Borgogna implica anni di studio e la possibilità di accedere a vini che i comuni mortali difficilmente possono permettersi per disponibilità e prezzo. I confini dei due ettari scarsi dell’appezzamento più prestigioso al mondo non si sono più allargati dal lontano 1580 e di conseguenza i litri di vino prodotto. Su un noto sito per vendita on-line, un Romanée Conti Grand Cru da 0,75 vendemmia 2000 è quotato 35 mila euro tondi tondi (e zero spese di spedizione) ma volendo, una bottiglia del vicino e sottovalutato Echezeaux Grand Cru, della stessa annata, può essere vostro con soli 2.800 euro.
TERROIR FRANCIA
Secondo alcuni esperti, anche in Borgogna c’è stato un tempo in cui tutti i vini tendevano ad assomigliarsi. Quel tempo in cui gli interessi dell’industria chimica si erano spostati dal settore bellico per rivolgersi all’agricoltura, tanto che il progressivo avvelenamento dei suoli aveva finito per portare, a fine anni settanta, alla cancellazione quasi totale dell’impronta del terroir e ad una evidente omologazione nella produzione vitivinicola. Allo stesso modo, secondo i vignaioli BIO sempre più numerosi in Borgogna, l’enologia tradisce il terroir quando ricorre a manipolazioni della materia prima, tanto legali quanto discutibili, per nascondere l’inconsistenza qualitativa di una zona non vocata, portando alla serializzazione di prodotti senza chiara identità e carattere. Eppure, come sostiene ancora Jacky Rigaux, “nulla impedisce di immaginare una viticoltura di altissimo livello che conviva pacificamente con una viticoltura di vini più modesti, economicamente accessibili, ma prodotti nel rispetto della natura su territori che non possono ambire allo status di grandi terroir”. L’esasperazione del concetto di eccellenza, supremazia, selezione, purezza e origine, suscita in me da sempre sentimenti contrastanti: se da una parte mi riporta col pensiero, anche solo istantaneo e probabilmente per ipersensibilità individuale, a una presunta nobiltà acquisita per diritto divino (tale da farmi desiderare una nuova marcia delle donne su Versailles) o peggio ancora a insulse ideologie razziali, dall’altra è un fatto che le zone più vocate rappresentino un formidabile elemento di traino per altre zone meno fortunate in quanto prive del medesimo pedigree pur producendo genuini vini di territorio. Ed ecco allora che, partendo dal più piccolo dei cru, allargando lo sguardo in progressivo zoom all’indietro, ci appare il macro terroir Francia, sigillo di garanzia grazie al quale l’intero comparto nazionale è in grado di piazzarsi sui mercati mondiali in posizione di vantaggio rispetto alla concorrenza.
L’ITALIA DEI COMUNI
Luigi Veronelli era convinto sostenitore della denominazione su base geografica (a partire da DOC e DOCG per le quali comunque non risparmiava critiche) attraverso sottozone, comuni (le famose De.C.O. o Denominazioni Comunali d’Origine) e frazioni fino ad arrivare alla granularità del cru e della vigna.
Nel 1995, all’interno del suo Novissimo repertorio dei vini italiani riportava: “Nessun altro paese al mondo è più vocato del nostro che produce vini in ogni regione, dal nord estremo della Valle Isarco al sud profondo di Pantelleria, con una inesauribile varietà e ricchezza di climi e di conformazioni geologiche […] L’Italia è diventata grande madre di grandi vini perché ha prevalso la teoria dei cru”. Rileggendo a ventisei anni di distanza, vengo assalito da più di una perplessità rispetto all’ultima sentenza, ma rimane impressionante la mole di dati archiviati su vini e zone. Eppure Gino stesso ammoniva: “sono troppo poche le esperienze di una vita sola e ancora troppo vaghe le informazioni raccolte”. Infine, a valle di questo certosino lavoro di catalogazione si domandava: “chi provvederà allora alle relative determinazioni e classifiche? Certo, potrebbe, o dovrebbe, assumerne la responsabilità un organismo pubblico sulla base di seri studi condotti da tecnici, capaci e super partes, nell’ambito di un catasto viticolo che, un giorno o l’altro, dovrà pur essere compiuto”.
Un tentativo si sta facendo a Barolo pur tra mille difficoltà, per il resto non mi pare siano stati fatti passi in avanti determinanti. Il Chianti, per il consumatore sprovvisto almeno di un diploma WSET, resta una giungla inestricabile nonostante un nome mitico e alla faccia dei confini tracciati per la zona classica già nel 1716 da Cosimo III de’ Medici. A Montalcino, al netto della presenza di vigne storiche tra le più blasonate al mondo, molti produttori non si fanno problemi ad assemblare uve provenienti da vigne molto diverse; anzi, la possibilità di mescolare zone fresche e calde, con differenti esposizioni, terreni e sistemi di allevamento, rappresenta per taluni la chiave per raggiungere quell’equilibrio divenuto sempre più precario a causa del cambiamento climatico. Sulla sponda veronese del lago di Garda, il Consorzio del Bardolino ha di recente istituito tre sottozone, denominate cru, che ridefiniscono l’assetto dell’attuale docg, col rischio di alimentare (nonostante le migliori intenzioni) un po’ di confusione. Per contro si registra il clamoroso successo mondiale della DOC Prosecco nonostante la smisurata estensione su due intere regioni (Veneto e Friuli) e il totale di quasi mezzo miliardo di bottiglie prodotte ogni anno, non giochino a favore della sua credibilità. Ma dopotutto i consumatori bevono vino e non mappe catastali e i produttori potrebbero anche averne piene le scatole di addizionale burocrazia da sbrigare.
TERROIR UTOPIA
Nella mia concezione il vino continua ad essere essenzialmente un prodotto agricolo frutto del lavoro contadino con una storia millenaria ricca di intersezioni e contaminazioni tra uomini, territori e culture. Per citare un esempio contemporaneo, nessuno si sognerebbe di affermare che Joško Gravner ha smesso di produrre vini di territorio con l’introduzione dei qvevri a seguito del suo viaggio in Georgia; che poi l’anfora vinaria vino più antica mai ritrovata, ancora sigillata e in perfetto stato, è etrusca e magari Joško poteva risparmiarsi un bel pezzo di strada! E’ possibile che non tutto obbedisca ai principi della piramide qualitativa al cui vertice stanno i cru. E per contrapposizione, non è detto che tutto il resto del buon vino debba, per forza di cose, seguire le rigide regole della produzione industriale omologata e seriale. Le eccezioni sono il sale della vita dell’enofanatico e la storia che vado a raccontare ne è solo un microscopico esempio.
Una cisterna di cirò che lascia la Calabria in direzione nord, un lotto di barbera d’Asti in viaggio verso la costa adriatica, un carico di dolcetto in partenza dall’ovadese per la medesima destinazione, una botte di montepulciano che attende in terra marchigiana. Niente scandali, questa è solo una bella storia!
Le aziende A’Vita di Cirò Marina, La Viranda di San Marzano Oliveto, Valli Unite di Costa Vescovato e Aurora replicano da quasi un decennio l’allegro rito di mescolare, in modo tanto naturale quanto iconoclasta, parte delle rispettive vendemmie per dare vita grazie a Franco, demiurgo presso la cantina di Offida, a un vino senza confini né barriere: il Rossounito. Tutto qui? Solo quattro amici, veraci interpreti dei propri rispettivi territori, riuniti sotto l’ombrello di un improbabile blend enologico? Nulla di eclatante, forse, se ci si limita a una tale superficiale lettura. Il sognatore che è in me si ostina a vederci molto di più, ovvero un progetto per un vino avanguardista e arcaico in palese controtendenza che non teme di cadere in contraddizione.
Il Rossounito non rinnega la definizione comunemente accettata di terroir ma ne ricalcola le coordinate introducendo un nuovo livello trasversale, il substrato culturale degli ideali condivisi, una sorta di terroir-utopia, che pone in primo piano la visione globale della gestione e del rispetto della grande madre terra, della vite e della vita di coloro che la lavorano, al di sopra della specificità della singola mattonella di crosta terrestre dove ci si posiziona. Un vino politico, profondamente autoctono ma concettualmente più internazionale (internazionalista?) di un taglio bordolese. Un vino schietto, lontano da una qualsivoglia idea di capolavoro enologico perché fondamentalmente se ne frega. Un vino birichino in grado di far ammattire il più esperto dei degustatori in una sessione alla cieca. Fatelo assaggiare ai francesi arroccati nei loro grand cru come gli Atuatuci, spiegategli com’è prodotto e probabilmente otterrete l’effetto Giulio Cesare!
Il Rossounito non conquisterà riconoscimenti o premi di sorta ma è comunque un vino gradevolissimo, in armonico equilibrio tra potenza e freschezza, grazie al carattere del montepulciano piceno, l’acidità della barbera d’Asti, la vena rustica del dolcetto di Ovada e la trama tannica del gaglioppo cirotano. Un vino che per forza di cose non può fregiarsi di alcuna denominazione né dell’annata di riferimento (comunque determinabile attraverso il lotto). L’etichetta blu bevuta di recente, a ben dieci anni dalla vendemmia, mi ha davvero stupito, mentre l’annata 2016 è ancora un pizzico ruvida con la viscerale nota scura e un po’ selvatica del montepulciano in primo piano.
Franco mi suggerisce dalla buca: “quel millesimo è costituito da montepulciano Aurora al 40%, gaglioppo A’ vita al 25%, barbera La Viranda al 20% e dolcetto Valli Unite per il residuale 15%. Con questo quartetto abbiamo realizzato sei annate, anche se ogni volta le percentuali erano un po’ diverse. Ci incontravamo e bevendo e chiacchierando usciva fuori l’assemblaggio… un paio di volte abbiamo sostituito il dolcetto con la croatina. Oggi è in commercio il 2018 che è un blend di tre diversi montepulciano: il nostro e quelli di La Marca di san Michele da Cupramontana e Podere S.Biagio da Controguerra in Abruzzo”.
Per una volta tanto mi sento di perdonare la quasi totale assenza di informazioni in etichetta in favore della seguente dichiarazione d’intenti: “questo vino nasce da un progetto tra viticoltori provenienti da territori lontani ma vicini nei valori e nel modo di sentire, che vogliono confrontarsi, rompere stereotipi culturali ed affermare la superiorità della sola ed unica madre terra, mescolare la passione per la vita/e e i suoi molteplici linguaggi per dare l’avvio ad un’unica musica”.
Penso al melting pot gastronomico-musicale cantato da Joe Strummer in “Bhindi Bhagee”. La canzone racconta di uno spaesato neozelandese appena giunto a Londra che chiede all’ex-Clash dove possa gustare una semplice crema di piselli. Joe ci pensa un attimo e risponde: “No, non ne troverai qui attorno…In compenso puoi trovare.. Balti, Bhindi rigorosamente Hindi, Dall, Halal e proseguendo sulla strada Rocksoul, Okra, Bombay-Duck, Shrimp-Beansprout, Bagel, Avocado, Empanada, Akee, Lassi, Baccy, Somalo-Waccy e son sicuro che conoscerai Tikka, Hummus, Cous-Cous, Pastrami, Salami e lasagne d’asporto”. Il tipo ringrazia e domanda quale genere di musica suoni la sua band. “…uhm…beh…sai… una specie di… come dire…una sorta di…ragga-bhangra-two-step-tanga-mini-cab-radio-music-on-the-go-surfbeat-backbeat-frontbeat-backseat-brit-pop-hip-hop-rockabilly-lindy-hop-gaelic-heavy-metal…”. Meraviglioso!
Senza il talento di uomini come Joe Strimpellatore anche un grande terroir musicale come Londra sarebbe rimasto solo una speranza. Forse il vino, come la musica, non è nato per essere settario, elitario, esclusivo. O forse, più semplicemente, c’è spazio per tutti e per tutto. Forse, forse, forse… Come al solito molte domande e mai lo straccio di una risposta che non puzzi di dubbio e provvisorietà.
Mi appoggio al comò, nel lettore gira Joe di Global a Go-Go; La Tâche è finito, tempo di stappare un Rossounito.





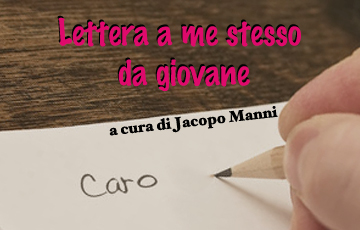






5 Commenti
Sancho P
circa 3 anni fa - LinkRossounito mi apre un cassetto di ricordi. Tra tutti gli eventi le fiere perse a causa di questo maledetto virus, Enotica è quello di cui ho sentito maggiormente la mancanza.
RispondiLanegano
circa 3 anni fa - LinkApplausi scroscianti al redattore dell'articolo. E anche a Joe Strummer.
RispondiFrancesco Romanazzi
circa 3 anni fa - LinkGrazie per queste belle e utili riflessioni. La ricchezza è nelle differenze e nelle sinergie, concetto tanto semplice quanto difficile, evidentemente, da far comprendere a molti.
RispondiHazel
circa 3 anni fa - LinkCome mi manca Joe, quanto manca al mondo
Rispondimarcow
circa 3 anni fa - LinkJoe Strummer: "Pensare è il motivo per cui svegliarsi la mattina" __ Penso che uno dei traguardi più difficile da raggiungere durante tutta una vita sia... imparare a pensare. E, soprattutto, diventare indipendenti: pensare con la propria testa. __ L'articolo è interessante... proprio perché stimola... il pensiero, la riflessione. Nell'ultima parte intravedo delle riflessioni che condivido. Il concetto di terroir è molto più complesso e problematico di quel che sembra. Il fatto stesso che nel web, e anche in Francia, ci siano diverse sfumature semantiche dovrebbe far riflettere... far pensare. In certe definizioni i fattori umani vengono presi in considerazione mentre in altre definizioni soltanto i fattori ambientali. E ancora tra le definizioni che esaltano i fattori ambientali c'è chi 1 limita i fattori ambientali al suolo 2 chi ai fattori climatici 3 chi li prende in considerazione con diversa importanza. Secondo me, inserire i fattori umani(ciò che si fa in vigna e in cantina) nella definizione di terroir sconvolge il concetto di terroir. Lo indebolisce, invece di raffozzarlo.
Rispondi