Lucio Rossi, un jukebox di storie da ascoltare rapiti
di Massimiliano FerrariCOME UNA NAVE IN BOTTIGLIA
Mi hanno sempre colpito quelle bottiglie contenenti piccole ed esatte riproduzioni di navi in miniatura. L’idea stessa che copie esatte di galeoni, fregate e velieri, abituate a solcare i mari, possano essere racchiuse in un involucro di vetro rappresenta quasi un’incongruenza con la realtà.
Quando ho iniziato ad intercettare le prime voci che mi parlavano di Lucio Rossi, a raccogliere frammenti e schegge sparse che ne componessero un ritratto, ascoltandolo poi raccontare aneddoti e storie e, in ultima battuta, provando a mettere insieme le tessere di quel collage che è stata la sua vita, ho avuto come l’impressione di ritrovarmi a ripetere le stesse azioni che compie chi mette mano alla riduzione di quei legni da mare dove, un pezzo alla volta, invece di dare forma ad un vascello da guerra ho liofilizzato il ritratto di Lucio in questa bottiglia sbrecciata fatta di parole.
Il suo nome salta fuori quando, seguendo le tracce di quella iniziativa pregevole che si chiama A vin di bene, incontro idealmente Lucio sotto una pergola centenaria. Se quelle bottiglie solidali esistono e tengono in vita un sogno parte del merito se lo prende anche Lucio e il suo savoir-faire nell’essere artigiano di vino.
Nel frattempo mi arrivavano bisbigli e sussurri che magnificavano la sua malvasia segreta, nascosta e inafferrabile, come un tesoro piratesco.
Inizialmente di Lucio sapevo poco: un paio di articoli letti sui suoi spettacoli, qualche chiacchiera qua e là, il fatto che lui stesso facesse vino, ma intanto inconsapevolmente stavo prendendo le misure del personaggio e già fantasticavo di scrivere qualcosa su di lui.
Fotografo da una vita e produttore di vino in proprio da altrettanto tempo, creatore e animatore di quel piccolo miracolo messo in scena a metà fra il vaudeville, il caffè-concerto e l’improvvisazione teatrale che risponde al titolo di Via Nino Bixio, un clamoroso caso di successo degli ultimi sonnolenti anni parmigiani, ma anche creatore con risultati fra l’eccellente e il sublime di acciughe oltreché di un olio d’oliva rigorosamente abruzzese, cittadino onorario di Santa Margherita Ligure dove conosce ogni pietra del porto e di cui è cantore di pescatori, pescherecci e pescati. Ma rinchiuderlo fra queste quattro etichette è un puro esercizio di riduzione.
Fatto sta che, seguendo percorsi casuali di conoscenze e attraversando qualche grado di separazione, è stato lui a bussare alla mia porta.
Una mattina di fine marzo mi arriva una telefonata e dall’altra parte del telefono c’è la voce limpida di Lucio Rossi condita da un accento che non ne tradisce le origini.
Dopo un veloce scambio di convenevoli mi invita, appena la quarantena lo permetterà, ad andarlo a trovare nel suo studio dove, davanti ad una bottiglia della sua malvasia, mi avrebbe raccontato qualcosa di sé.
Intanto i giorni di isolamento passavano e il pungolo di tracciarne un ritratto che prendesse forma attraverso i suoi innumerevoli racconti, gli aneddoti esilaranti, gli incontri inaspettati, e le passioni brucianti, insomma una biografia alcolica e poco convenzionale di Lucio Rossi, è aumentato in maniera esponenziale.
Le chiacchierate con Lucio alla fine sono state più di una, così come gli assaggi del suo vino si sono ripetuti ad ogni incontro. Ed ogni volta è stata un’incursione all’interno del continente Lucio Rossi cercando uno svelamento impossibile mentre il suo vino guadagnava punti e onori ad ogni bevuta.
IL CONTINENTE LUCIO ROSSI
Ma chi è Lucio Rossi? La domanda implica nel postulante una disponibilità di tempo che può andare da zero all’infinito.
Perché Lucio inizierà a raccontarti delle sue radici, divise fra la Bassa paterna e i monti appenninici della madre, ti inchioderà alla sedia con quel poema in sberleffi, storielle, grugni e voci che è il suo Oltretorrente, serbatoio di tipi umani che l’occhio vivente Rossi ha registrato sulla pellicola della sua memoria, e mentre cercherai riparo da quella favella indemoniata lui ti strapperà dal torpore con i ricordi del suo lavoro di fotografo ai quattro angoli del mondo e con le istantanee di Santa Margherita Ligure, sua seconda patria, accennando magari qualche strofa di una canzone lontana. E se non bastasse, ad accompagnare ci saranno le amate e pregevoli acciughe che sala e prepara da anni personalmente e le imitazioni che saltano dall’accento ligure di un maestro d’ascia a quello abruzzese degli amici pescatori per finire con il dialetto nostrano con cui concluderà il suo show infilando qualche battuta fulminante.
Ultimo di otto figli, Lucio mette insieme l’anima terragna e liberale del padre originario di Zibello capitale riconosciuta di nebbie e norcineria, con lo spirito aereo e autarchico delle valli appenniniche da dove arrivava la madre, nella fattispecie il piccolo borgo di Scurano.
Anche lui nato a Zibello, Lucio è ormai parmigianità personificata fino all’ultimo riccio di barba.
Lucio cresce alle porte di barriera Bixio, ingresso vero all’Oltretorrente parmigiano, in uno storico palazzo dove, tra gli altri inquilini, trovava posto il portinaio Marini, “uno che appena finito di servire a messa andava in piazza a distribuire l’Unità.”
Quando si tratta di scegliere cosa studiare all’università Lucio vira su studi di biologia. Percorso senza sbavature il suo ma intorno alla metà degli anni Settanta scattare fotografie gli sembra professione ben più stimolante che studiare molecole e cellule e così nel 1976 prende la licenza da fotografo iniziando un’avventura professionale che dura ancora oggi.
Ricordati, mi dice, che la scuola di fotografia di Parma è stata la seconda in Italia dopo quella fiorentina con gli Alinari. Qui abbiamo avuto grandi studi e grandi artisti-fotografi come studio Amoretti, studio Vaghi, Carra, Libero Tosi. Veri maestri del mestiere di fotografo.
Uno studio storico quello che fonda con i soci Brunetto Corrain e Pietro Ronchini, una rocambolesca epopea professionale che porta Lucio a lavorare con le principali aziende della città parmense: Barilla, Ocme, Rosa dell’Angelo tra le altre ma anche Voiello, Cademartori, Salvarani, consorzio Parmigiano-Reggiano e la lista potrebbe continuare a lungo.
Lucio mi racconta di una stagione in cui fare fotografia industriale, questa la sua specializzazione, significava avere attitudini di scenografo, occhio da ritrattista, mano da carpentiere e gusto da gourmet. Vedere alcune lastre di scatti fatti per Barilla mi fanno capire che il passaggio dall’analogico al digitale è stata una svolta epocale. Gli archivi che Lucio conserva sono una miniera di storia della fotografia industriale.
La fotografia per me è stato un lasciapassare potentissimo; dovunque andassi ero sempre carico come un mulo di macchine e attrezzatura e oggi mi ritrovo con sei ernie nella schiena! Appena finivo di scattare nelle aziende uscivo per strada e continuavo a fotografare per conto mio.
All’epoca si lavorava come matti, capitava di rimanere in studio fino a mezzanotte e poi in giro a vivere la notte. Io per dodici anni non mi ricordo di essere andato a letto.
La fotografia funziona come un passaporto nella vita di Lucio, lo porta a girare mezzo mondo per fotografare impianti industriali, linee di imbottigliamento e macchine di ogni tipo.
Erano anni in cui potevi capitare in Mongolia o Sud America e avere l’orgoglio di vedere che ogni macchina che fotografavo aveva un’etichetta che ne certificava la fabbricazione in qualche azienda dalla provincia di Parma. Era una cosa di cui essere orgogliosi.
Epoche lontane, quando artigianato e industria si davano ancora del tu.
IL VINO, LE ACCIUGHE, LA MUSICA E ALTRI AMORI
Il physique du rôle di Lucio non richiama quello di un agricoltore né tantomeno di un vignaiolo. Piuttosto barba e capelli, di un candore d’altri tempi, rimandano alla figura, mandata a memoria da ogni parmigiano, di Giuseppe Verdi.
Ma del patriarca dell’opera italiana Lucio possiede solo assonanze tricologiche. Il viso e gli occhi sono quelli in movimento continuo di un marinaio di lungo corso mentre la gestualità è più vicina a quella di un presentatore di cabaret piuttosto che di un direttore di orchestra.
Nonostante le apparenze, Lucio è un produttore di vino in incognito da più di trent’anni.
Il signor Rossi inizia infatti a sporcarsi le mani con mosti e uve nel 1984, complice un retaggio familiare che gli scorre dentro.
Il vino, da quando ho memoria, è sempre stato presente nella mia vita. Mio padre lo voleva sulla tavola pranzo e cena, non perché fosse un forte bevitore, ma era convinto, lui medico, che un bicchiere di vino genuino e buono fosse indispensabile. A patto che fosse rosso. E così la tradizione di farsi il vino per sé è una tradizione che ha sempre avuto dimora in casa mia.
L’idea di sottofondo è quella di avere il vino sempre a disposizione, che capiti un amico a casa o che ci sia da organizzare tavolate con amici e sodali una bottiglia buona non deve mancare. Nessuna velleità commerciale, solo autoconsumo.
La mia malvasia è diventato il vino ufficiale per pranzi e cene con amici, per improvvisati ritrovi, per notturni concistori con pescatori.
Ha iniziato comprando l’uva da un agricoltore in Val Tidone, ultima propaggine piacentina prima di entrare in Oltrepò pavese, da cui continua a rifornirsi anno dopo anno. Io gli chiedo sempre l’uva più balorda ma lui mi da sempre quella più matura che mi fa un grado saccarometrico alto!
Qualcuno lo chiamerebbe garagista, tuttavia sottostimandone le capacità affinate in anni di apprendistato e supportate dagli studi universitari in biologia.
Mi ricordo che l’allora direttore dell’enopolio di Parma, il dottor Lino Pin, mi faceva ogni anno i complimenti per il mio vino quando glielo portavo per le analisi: figliolo fai un vino che è la fine del mondo!, mi dice Lucio esibendosi in una perfetta versione del dialetto veneto del sopracitato Pin.
Il vino per Lucio è qualcosa in più di una semplice bevanda idroalcolica, diventa un collante liquido, un flusso che porta le persone a incontrarsi, la sua malvasia bagna le chiacchiere, diventa merce di scambio con pescatori, sacramento per officiare tavolate notturne infinite, liquido con cui benedire canzoni e suonatori. Dove c’è il vino compaiono gli amici, si mette in tavola qualcosa da mangiare, si tirano fuori le chitarre, le voci si scaldano e si può iniziare.
La malvasia di Lucio non prende vita in una cantina rustica o in qualche moderna struttura. Le sei, settecento bottiglie che ogni anno produce prendono corpo e anima nel suo garage in città, due cisterne in acciaio, pulizia estrema, lieviti selezionati sempre, minime quantità di acido tartarico biologico per compensare la maturità spinta delle uve, qualche travaso necessario per tenere il vino non troppo chiuso e poche altre concessioni ad un’enologia protocollare.
La malvasia di Lucio è tutta qua ma si dimostra essere un vino di estrema definizione. È un ingranaggio perfetto di tutte le parti in gioco, chiaro nelle note aromatiche della malvasia di candia ma rivelatore dell’annata, dove ad un 2019 più nordico, meno concessivo nel frutto e dotato di una carbonica fine ed elegante si contrappone una versione 2018 più esuberante, dorata e luminosa, con un frutto più maturo, pesca e albicocca, e una chiusura furba e amaricante che spinge a tornare al bicchiere in modo ripetuto. Un vino Sophia Loren quest’ultimo, più Catherine Spaak il 2019, ha suggerito qualcuno con sintesi perfetta…
Al di là degli accostamenti femminei, sperando che non ci siano produttori permalosi all’ascolto, sono convinto che la malvasia di Lucio metterebbe in fila tanti vinelli che si producono oggi nel comprensorio emiliano.
Per Lucio è impossibile parlare di vino senza tirare in ballo tutto quello che gli gira attorno. Al vino si accompagna la convivialità che trova espressione nei banchetti e nelle mangiate fra amici, nei quali la musica è un sottofondo che non manca mai.
Basti pensare ai suoi spettacoli dove, accanto a lui, sul palco si sono esibiti tanti musicisti diversi, Juan “Flaco” Biondini storico chitarrista di Francesco Guccini, è uno dei più assidui partecipanti.
Tuttavia questo 2020, anno zero dell’epoca covid, porta un grosso rammarico per Lucio, compio gli anni il primo maggio e quest’anno è stato il primo dal 1974 che non siamo riusciti a radunare tutta la compagnia. Siamo di solito dalle ottanta alle cento persone fra amici, vecchi compagni di scuola, parenti dove di solito ci si mette a tavola a mezzogiorno per alzarsi non prima di mezzanotte. Veicolo fondamentale è la mia malvasia, un centinaio di bottiglie sono il valido stampella su cui appoggiarsi.
Seduti ad un tavolo, alla giusta distanza, capisco che la narrazione di Lucio ha un altro polo attrattivo fortissimo, cioè il mare.
Grande privilegio della mia vita è stato incontrare Santa Margherita Ligure, dove mio padre ci lasciò una casa. I miei pomeriggi sanmargheritesi sono sempre stati in porto. Ho sempre frequentato i pescatori, li conosco tutti, con tutti c’è uno scambio, di pesce e vino, di fotografie e insegnamenti.
A Santa Margherita Lucio possiede anche una piccola barca dal 1984, una spagnoledda di sette metri, riverniciata recentemente di rosso vivo come un vino giovane. E’ il pegno che paga ad una passione bruciante.
Lucio si definisce un palangaro, cioè quel sistema di pesca che prevede una lunga lenza madre alla quale sono attaccati a intervalli regolari tanti diversi ami e usata soprattutto nell’Italia meridionale per pescare sia in superficie che in profondità.
Questa appartenenza è molto forte e ricorda quasi l’attaccamento che i contradaioli senesi hanno per la propria contrada. Palangaro una volta, palangaro per sempre.
Da ragazzo ho fatto anche qualche regata importante, ma ti dico sinceramente è stata una parentesi breve perché io andare in cima ad una barca e non pescare mi rompo i coglioni!
Nel corso degli anni Lucio ha creato un forte sodalizio anche con una colonia abruzzese di pescatori insediati a Santa Margherita. Da loro arriva anche il suo amore per l’olio d’oliva delle terre intorno a San Vito Chietino, costa abruzzese, altro luogo dove Lucio è accolto con tutti gli onori.
Alici liguri e olio abruzzese con la partecipazione di un peperoncino sempre d’Abruzzo nelle mani di Lucio diventano un piatto dove terra e mare parlano la stessa, superba lingua.
Lucio mi racconta che ogni volta che va in un posto di mare la prima cosa che fa è andare alla ricerca del porto peschereccio. Guardando le barche ormeggiate riesco subito a capire cosa si pesca. Lampare, palamiti, spadare, paranze…mi basta dare un’occhiata e ti so già dire cosa si mangia.
La frequentazione fra Lucio e i porti di mezza Italia è una lunga storia, mi sono imbarcato sulle lampare di Ortona e Sestri Levante, ho partecipato alla pesca dei tonni in Sicilia, ho fotografato le mattanze a Carloforte invitato da Luigi Pomata, a mio parere chef del miglior ristorante della Sardegna, col quale si era anche parlato di mettere insieme un libro di fotografie. Ancora un crocevia di cibi, fotografie, mare e spiriti affini.
LA TANA DEL LUCIO
Il suo quartier generale oggi è un capannone anonimo incastrato fra la periferia est di Parma e la tangenziale che corre lì accanto. Non c’è un’insegna, né targa o indicazione che segnali lo studio del Lucio. Quando arrivo, in un tardo pomeriggio umido, ci metto qualche minuto a rintracciare le informazioni che mi aveva dato al telefono.
Ma basta varcare l’ingresso perché l’atmosfera grigia e industriale dell’esterno lasci spazio a quella magica di una wunderkammer padana.
Si entra in questo casamento dal soffitto altissimo stipato di oggetti di qualsiasi tipo. Sulle prime sembra una via di mezzo fra il magazzino di un impresario teatrale e un bric-à-brac di un mercante che ha visto tutto e girato il mondo.
Perché se quello che in teoria dovrebbe essere lo studio di un fotografo, luci, riflettori sfondi e attrezzature sono prove a carico, alla prova dei fatti si rivela essere uno strabordante ricetto di memorabilia di ogni tipo, quadri modellini di velivoli appesi al soffitto e poi una colonna di valigie stile migrante anni ’30, maschere libri fotografie una collezione di tostapane e piccoli ventilatori, tanti quadri e manifesti luci di posa libri dischi…e ovviamente un desco apparecchiato alla buona dove prenderò posto per immergermi nell’oceano di storie di Lucio accompagnato da una delle sue bottiglie.
UN JUKEBOX DI STORIE
Le mie conversazioni con Lucio sono state giri sulle montagne russe della sua memoria e della sua vita.
Fotografia, vino, acciughe, Santa Margherita Ligure, le strade dell’Oltretorrente, le osterie di una volta, quando apre il gas diventa impossibile racchiudere Lucio in quelle gabbie fatte di domande e risposte, costringerlo in un canovaccio che rispetti le convenzioni fra intervistato e intervistatore.
Lucio Rossi si trasforma in quello che racconta, i dialetti si mischiano alla lingua italiana, toni accenti sfumature diventano quelli di questo o quel personaggio, le mani si muovono incessanti, gesticolano, diventano strumenti di questa prova d’attore popolare e nobile allo stesso tempo dove, ogni volta, si assiste alla replica di uno spettacolo unico che poi è Lucio stesso, soggetto e oggetto della sua personalissima pièce teatrale.
Sono tante, forse troppe le storie che riversa Lucio. E ogni volta che inizia con un episodio nuovo, un aneddoto inedito mi chiedo dove abbia lo spazio fra quella barba curata e quegli occhi chiari per contenere tutto questo materiale di vita e persone, come faccia a ricordare nomi, luoghi, ricordi, incontri fuggevoli di un attimo. Il repertorio è vasto, un jukebox vivente dove non serve nemmeno inserire una monetina, ma è sufficiente indirizzare la domanda giusta accomodarsi in poltrona e lo spettacolo ricomincia.
C’è quella del pescatore abruzzese e del suo coltellino Opinel con cui poteva pulire pesce per dieci persone oppure preparare una brodo di rana pescatrice memorabile in un capodanno degli anni Settanta, c’è quella di Silvano Pantesco, geniale interprete di palchi e parole recuperato a Rimini nottetempo e portato a Parma per tre spettacoli memorabili e poi sparito nuovamente.
Ci sono poi le storie del bar Ciano e quelle dell’osteria Dal Sordo, due degli indirizzi storici di una Parma che non esiste più, banchi di scuola dai quali Lucio ha raccolto fermi immagine di osti e avventori, filosofi da bancone e matti disperati, episodi leggendari e ricordi di un mondo perduto.
Come quella delle polpette che Bruno Luchini alias il Sordo, gestore dell’omonima taverna, si portava nelle tasche del grembiule per dispensarle ai frequentatori abituali, che potevano essere accompagnate da un bicchiere di “seveso”, il bianco dalle micidiali similitudini o dal lambrusco “gassificato artificialmente”, come recitava l’etichetta handmade, dove in entrambi i casi colossali mal di testa erano il pedaggio da pagare.
Ma nella rete da strascico di Lucio si può trovare un po’ di tutto. Come una cena inaffiata di vino e tante chiacchiere con Leo Ferré, reduce da un concerto parmigiano reso turbolento da alcuni contestatori che lo stesso cantautore anarchico zittì in un palazzetto imbarazzato oppure un incontro che è rimasto nel cuore di Lucio, quello con il fotografo brasiliano Sebastião Salgado.
Salgado si trovava a Parma per un reportage commissionato dall’amministrazione dell’epoca. Quindici fotografie che rappresentassero lo spirito della città e della sua gente. Per una di quelle inconsuete coincidenze che a volte intervengono nelle vicende umane nello studio di Lucio una sera arriva Salgado accompagnato da un’amica comune.
Lì per li Lucio è preso in contropiede ma, con buona capacità di improvvisazione, invita Salgado a casa propria per cena con la promessa di farlo mangiare come e meglio che al ristorante.
Una grandiosa pastasciutta saltata, quelle acciughe, parmigiano reggiano, salumi e la sua ubiqua malvasia sono gli ingredienti di una serata fra due fotografi, dove la fotografia non viene mai menzionata, in una sintonia speciale che a volte si crea quando ad incontrarsi sono uomini altrettanto speciali. Non ci si alzerà da tavola prima delle 3 di notte, mi racconta Lucio, dopo aver parlato di cibo, Amazzonia, bellezza del mondo, progetti futuri e tanto altro. Il commiato di Salgado sarà l’incancellabile ricordo della cena migliore della sua vita.
La fantasia vola e mi immagino un racconto filmico della vita di Lucio e di episodi come quello appena tratteggiato girati da Ermanno Olmi, maestro purtroppo scomparso, che ha saputo raccontare in maniera profonda uomini, vino e terra.
UNA FINE?
Siamo quasi arrivati alla fine e il vino di Lucio, la sua malvasia, la apriamo un venerdì sera di inizio giugno a tavola, ben distanziati, nel suo studio. Tre bicchieri, insieme a me e Lucio c’è anche il professore e vignaiolo Michele Antonio Fino, amico del nostro, di passaggio per una tappa ristoratrice nello studio-rifugio prima di riprendere la strada di ritorno verso le casalinghe valli del Monviso.
Lo scenario è quello rilassato e amichevole di due amici che si incontrano, chiacchierano, ridono in una bella simbiosi padano-alpina dove io sono un terzo incomodo che cerca di mimetizzarsi e ascoltare silenzioso. Alla tavola fanno ovviamente la loro comparsa anche le arcinote acciughe con cui, arrivati a questo punto, avrete ormai familiarizzato.
Del vino vi ho già raccontato, mentre delle chiacchiere fatte mi sembrerebbe irrispettoso svelare qualcosa.
C’è una frase dello scrittore britannico Christopher Isherwood che nello scrivere, questo lungo post in parte ritratto, in parte biografia anomala e in parte trascrizione di uno spettacolo umano, mi ha continuato ad accompagnare e che credo sia calzante nel descrivere Lucio, ed è questa: sono una macchina fotografica con l’obiettivo aperto.
Lucio è un obiettivo rimasto sempre spalancato su quello che ha visto e sentito, sulla commedia umana su cui ha posato lo sguardo, senza perdere un particolare, un vezzo, un tic, un inflessione di tono e voce. Registrando tutto, sempre con misura e umanità. Come mi ha suggerito un amico comune, Lucio è un aristocratico dello spirito, un uomo che potrà perdere una guerra ma non una battuta.
E mi piace anche pensare che la sua malvasia sia un condensato in vino di questo modo di essere, una bottiglia in cui troviamo tutto Lucio e quello che è ed è stato finora.
Un vino che mette a fuoco tutta una vita e quella che verrà.





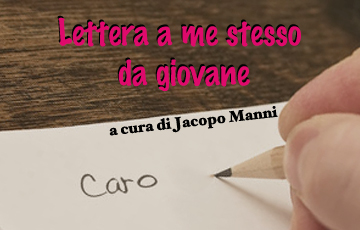






2 Commenti
Magazzino M.
circa 4 anni fa - LinkUn articolo si lungo, ma piacevole da leggere....e fino alla fine! Complimenti! Mi è piaciuto, oltre che all'argomento, le metafore fatte! Hanno reso l'argomento più armonioso! Alla prossima!
RispondiMassimiliano
circa 4 anni fa - LinkBeh grazie per le belle parole spese e per la pazienza nell’essere arrivato fino alla fine!
Rispondi