La schiava della memoria e quella che bevo ora
di Massimiliano FerrariScrivere della schiava è un pungolo che mi premeva da giorni, settimane, anni forse.
Un amore malinconico, di quelli che si tengono nascosti, di cui forse ci si vergogna anche un po’. Sedotta e abbandonata, ripresa e poi dimenticata, la schiava è un vino che ho cercato, bevuto, poi rigettato, dimenticato e poi sono tornato a bere. Cercavo la sua presunta fragilità, il suo essere scanzonata, un sorso che spegneva la sete, ma capace di sorprendere, di scatti di personalità che mi hanno fatto vacillare e tornare sui miei passi. Cantava Venditti che certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano.
I miei primi ricordi della schiva schiava sono offuscati, persi a ritroso in anni in cui l’unica cosa che sapevo del vino era che si metteva a tavola per pranzo e cena.
Perché tutto iniziò con un viaggio fra valli trentine, in compagnia di mio nonno, per andare da un vecchio contadino ad acquistare il vino che produceva per sé e qualche fedele avventuroso. Viveva solitario al confine fra Trentino e Alto-Adige in una vecchissima casa in sasso, senza riscaldamento, dove pulizia e ordine rimanevano fuori dall’uscio. La vigna era una pergola che presidiava lo spazio fra il bosco e l’abitazione. Il vino veniva travasato nel cortile, fra galline libere e vecchi attrezzi, da grosse damigiane direttamente nei bottiglioni di vetro opaco portati da casa. L’eremita silenzioso e mio nonno si scambiavano poche e scarne parole durante queste visite in un dialetto oscuro e gutturale. Al termine delle operazioni di imbottigliamento si pagava e, senza troppe cerimonie, si riprendeva la via di ritorno.
Qualche anno fa, indagato il nonno su che vino fosse, ho scoperto, con fatica e al netto di ricordi confusi, che quel vino era vernatsch. Così veniva chiamata, in tedesco, e mi confida anche che era il vino che negli anni Cinquanta i taglialegna – come lui un tempo – si portavano dietro durante il lavoro nei boschi.
Con quel nome che sembra un grugnito si identificava qualcosa di nativo, domestico, come appunto è la schiava, vino di casa, vino apparentato con la terra di queste valli alpine. Perché a sud del Tirolo, chiedere ad un altoatesino per conferma, il vino è la schiava, non il lagrein. Per tacere dei bordolesi, ovviamente.
Una e trina, la schiava diventa gentile, grossa e grigia o, rispettando il bilinguismo, trollinger, grossvernatsch e grauvernatsch. Una famiglia allargata diciamo.
Dire schiava è dire Alto-Adige, uva con doppio passaporto, italico e germanico. Coltivata da sempre in queste terre, anche se la si trova sparpagliata in altre enclave viticole del Nord Italia, si porta dietro il fardello e la diceria di dare vini semplici, di grana esile, da bersi nel giro di qualche mese.
Brutto anatroccolo fra i cigni dei vigneti montani, vaso di coccio costretta in mezzo ai vasi di ferro della viticoltura altoatesina, soffocata dalla voracità commerciale dei vari chardonnay, gewurztraminer, pinot grigio e bianco, cabernetmerlot vari. Oggi torna ad rialzare la testa grazie alle bizze di un mercato che chiede tutto ciò che quest’uva è in grado di mettere nel bicchiere. Leggerezza, vivacità e territorialità. Ma anche sfumature, chiaroscuri e inaspettata longevità dopo anni in bottiglia.
Già quel nome incuriosisce, porta a fantasticare sulla sua storia, indizio di una condizione, di un modo di stare al mondo.
Per certo non si sa nulla se non di trovarsi di fronte ad un bivio etimologico. Da una parte chi sostiene che sia schiava perché allevata a filare o a pergola e costretta a qualche supporto, per differenziarle dalle uve “maggiori” maritate a qualche fusto o albero.
L’altra ipotesi, geografica, ci porta verso le pianure della Pannonia, spazio compreso fra il Danubio e la Sava, da dove sembra che la nostra sia arrivata al seguito di truppe longobarde, passando da essere l’uva slava, sclava fino all’attuale schiava.
Uva meticcia, dall’origine incerta, emigrante in sella ai cavalli di truppe barbare, dalle fattezze slave. Forse oggi non passerebbe le frontiere.
Non cerchiamola sotto i riflettori la nostra schiava, occorre invece occhio allenato e disposto a perlustrazioni attente.
Oggi nel repertorio altoatesino è spesso rintanata ai margini, da bere giusto con speck e schüttelbrot, non adatta a sedersi alla tavola dei più nobili pinot nero e lagrein. Uva rossa delle retrovie, le prime notizie della sua coltivazione sono datate intorno all’anno Mille citate in documenti che attestano la vendita e il commercio delle uve da parte di conventi e ordini religiosi.
Se secoli fa la cura di vigneti e la produzione di vino passava da abbazie, monasteri e congreghe cristiane oggi sono le cantine cooperative, moderne cattedrali del vino, a disegnare la rotta nella viticoltura d’oltradige. La schiava vive su direttrici secondarie anche se qualche temerario produttore la pone al timone della propria navigazione.
Errore comune è di intraprendere sentieri scivolosi che portano sempre a giudicare i vini da schiava come leggeri e beverini, disimpegnati e semplici, effimeri e fugaci.
Come un sovrano raffazzonato e poco amato la schiava mantiene a fatica il trono di varietà più coltivata in Alto Adige, nonostante nel 1970 quasi il 70% della superficie vitata era a schiava, ma non mancano i colpi di mano per spodestarla e ogni anno che passa rosicchino spazi e terreni.
Sembra la diva di un vecchio film americano in bianco e nero, onori e applausi fino a quando non fanno la comparsa attrici più giovani, colori sgargianti e lei scivola dimenticata in un vecchio palco di provincia.
Ad un certo punto anche mio nonno smise di salire da quel vecchio contadino rintanato e di acquistare quel vino dal colore tenue e profumato di mirtilli e fragoline. Decise di bere rossi scuri, allungati con l’acqua, prodotti dalla cooperativa locale che glielo recapitava sull’uscio di casa. Segni dei tempi che cambiano.
Coniando una brutta espressione si potrebbe definire vino contemporaneo la schiava. Dopo le tante bastonate ricevute nel recente passato, oggi fa valere il proprio colore diafano ed un gusto spigliato come diplomi da incorniciare.
Contemporaneo nell’essere duttile e resiliente sulla tavola, contemporaneo ad un gusto dove freschezza e souplesse, bassa alcolicità e trasparenze sono i comandamenti da mandare a memoria. Come in un gioco di specchi la schiava si riflette in diverse forme e fattezze.
In questa nouvelle vague altoatesina ci sono produttori che tentano di modellare questi vini secondo forme nuove e inaspettate, consegnandoci liquidi che smentiscono tutti i luoghi comuni elencati sopra.
Bussare alle porte di Heinrich Mayr (Nusserhof), Hartmann Donà e Martin Gojer (Pranzegg), Tenuta Abraham o Girlan per avere la prova di schiave fatte per durare ed evolversi, mutare e mantenersi. Cercare le bottiglie di questi produttori diventa indispensabile per abbattere il muro delle ovvietà e avere un quadro più chiaro di quello che la schiava può offrire, sia in purezza che in versioni a cui si aggiungono in misura diversa lagrein o pinot nero per una volta come semplici comprimari, rimanendo dietro le quinte.
Ma l’Alto Adige tutto rischia di trasformarsi in un Risiko della schiava in cui ogni cantina diventa obiettivo degno di conquista e di bevute. Se basse rese e vecchie vigne sono diktat per ottenere versioni capaci di reggere anni se non decenni e avere liquidi meravigliosi, anche negli esiti con meno aspettative ci si troverà di fronte a bottiglie ben fatte, raramente deludenti.
Immagino che quel improvvisato vignaiolo che mio nonno andava a trovare una volta all’anno abbia già lasciato questo mondo e forse le sue vigne con lui. Ma mantengo nella memoria, come fosse oggi, quel suo vino malfatto, quella presunta schiava, che per me rimane un battesimo alcolico indelebile. E forse nelle schiave che bevo oggi continuo a cercare quei profumi lievi e quell’atmosfera scomparsa.





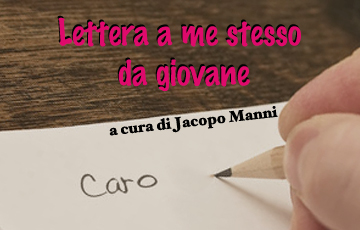






2 Commenti
Valter Genga
circa 4 anni fa - LinkMi farebbe piacere sapere notizie del vino
RispondiPatrick Jane
circa 4 anni fa - LinkTi ha fatto I nomi dei cinque migliori produttori, che sono quelli che posso consigliare anche io, armati quindi di cavatappi e assaggia a colpo sicuro!
Rispondi