Riscoprire l’enogastronomo Teofilo Folengo, cinquecento anni dopo
di Thomas PennazziTeofilo Folengo (1491-1544), dimenticato autore mantovano a 525 anni dalla nascita, è certamente da considerare tra i padri nobili della letteratura gastronomica italiana. Fu frate benedettino subcellerarius (cioè vice‑capo della cantina, della dispensa e della cucina) dell’abbazia di Polirone, al tempo detta la Montecassino del Nord.
Umanista e indisciplinato religioso vissuto tra i conventi dipendenti dal Polirone a Padova, Brescia, Cesena, Venezia e morto nel priorato di Bassano del Grappa, viene ricordato dai più per il suo latino maccheronico, idioma dei cuochi dei conventi, coi quali aveva a che fare nella quotidianità. La tradizione maccheronica non nasce con lui, poiché il genere letterario era già praticato da tempo e discretamente popolare tra uomini di chiesa ed umanisti; per maccherone dobbiamo però intendere lo gnocco, e non la pasta napoletana.
A chi si imbatte in questo scrittore salta all’occhio che, sotto quello che può sembrare solo un gioco linguistico, in realtà si cela una solidissima cultura latina, innovata dal gusto mai salace ma popolaresco nel senso più alto, diremmo antropologico, per la parola quotidiana. La sua lingua, ancora oggi facilmente intellegibile da chi abbia avuto i natali nella valle del Po ed una minima pratica di latino, è sì colta, ma pesca a piene mani dalla contemporaneità e dalla vita della campagna e del villano: nella sua opera più importante, il poema in esametri Baldus, un grande affresco epico in cui il protagonista è un eroe rustico, i riferimenti all’enogastronomia di principi e di popolo costituiscono una parte vitale della tessitura del racconto. Ecco per esempio lo scrittore stesso, perso sulle sue carte, sgridato dalla servetta perché indugia a venire a cena:
«Me dudum a studio chiamat fantesca: – Patrone,
iam depone cito pennam, calamaria, cartam,
coena parecchiatur, frigescit calda polenta,
compagni totam iam mangiavere salattam! -»
[Baldus, lib. XVI, 629-632 – a cura di E. Faccioli, Einaudi – 1989 ]
Padre letterario del molto più celebre Rabelais del Gargantua e Pantagruel, che del mantovano è profondo debitore, il Folengo con il suo Baldus ha fissato lo stile di questo genere: il poema alto nella forma, ma schietto, genuino e terra-terra nei contenuti, dove l’eroe è un omaccione buono prima di tutto a smontare tavole e triturare pollame e castrati, oltre a svuotare botti e tinozze, che a menare la spada. Ma qui, riflesso nella seconda strofa, vediamo anche l’ammicco al lettore da parte del Folengo, lui stesso gaudente e buon bevitore.
«Se fa merenda un vitelletto intero
E una corba di pane appena basta;
Si val d’una bigoncia per bicchiere,
E coll’oste pel vin spesso contrasta.
Ed ha ragion e anch’io lo vo’ sincero,
E sempre ho udito dir che l’acqua il guasta;
Pur non son bevitor come son tali,
E mi bastano cinque o sei boccali.»
[Macaronee, trad. G. Tonna, Feltrinelli – 1958]
Ma quello che più può incuriosirci è il racconto del vino nelle sue opere, una finestra illuminante sul mondo del bere al tempo rinascimentale. Senza pretesa, ché lascio volentieri a studiosi ed eruditi il lavoro serio, posiamo lo sguardo qua e là sui suoi versi.
Ecco la celebre enumerazione dei vini pregiati al termine del Libro Primo del Baldus, che contiene la descrizione del banchetto (Regalis Coena) offerto dal Re di Francia al vincitore del torneo cavalleresco:
«Ma più gradita di ogni cosa giunge finalmente in grandi vasi l’ostrica fumante, cui si suole accompagnare la malvasia, gloria d’ogni vino, in conformità al prudente motto dei padri, che dicevano: “Soltanto così smorzerai il fuoco col fuoco!”. Non mancò qui il vino strizzato dai racemi di Somma: Somma onore di Napoli e per contro crapula della gran Roma. Quel monte solitario produce infatti un vino, chiamato comunemente greco, che fa andare per traverso qualsiasi brigata. E insieme vi furono il mangiaguerra e la vernaccia di Volta e quella di cui si vanta la bresciana Cellatica. Quanto alle vigne del trebbiano di Modena, esse non occuparono certo il secondo posto; e così pure la moscatella perugina: due vini che riempiono di mille fantasticherie la testa dei panciuti tedeschi. E non mancarono nemmeno le vendemmie della tua piana, o Cesena, né le dolci orine che la Corsica è solita pisciare.»
[Baldus, lib. I, 497-511, op. cit.]
Sono passati secoli, e si vede: il panorama che ci offre il Folengo è molto lontano dal nostro: i vini sono prevalentemente bianchi e dolci, la Malvasia di Candia (veneziana?), il Greco di Somma Vesuviana, il nero e dolcissimo Mangiaguerra campano, forse di Gragnano, di cui il bottigliere (sommelier ante litteram) di papa Paolo III Farnese, Sante Lancerio, pochi anni dopo dirà “pericoloso per il clero, ma ideale per incitare la lussuria nelle cortigiane”, la Vernaccia di Volta Mantovana, e quella di Cellatica; il Trebbiano modenese, frizzante e pure dolce, così come il pregiatissimo Moscatello perugino, bottiglie di cui si sono perse le tracce; in compenso l’Albana di Romagna affascina ancora oggi come passito, e delle dolci orine di Corsica sopravvive un fine souvenir col nome di Muscat Blanc à Petits Grains du Cap Corse. Del lambrusco invece non v’è menzione nell’opera folenghiana se non in citazioni oblique: che non gli piacesse?
Ecco come invogliare a fermarsi il viaggiatore stanco ed affamato che smonta da cavallo alla prima locanda che incontra sul suo cammino: mai fidarsi degli osti, razza malnata!
«Tre sorti di vino di quello schietto, vuol spinare all’istante per te, perché tu possa assaggiare quello che ti sembra il migliore, sia che tu abbia qualche riguardo per lo stomaco, sia che tu indulga per abitudine al gusto della tua gola, che non gradisce se non quello dolce. Per primo vuol darti quello dolce per la zuppa, poi quello razzente, che quando lo bevi va a raspare nei penetrali del ventre. Che cos’è che non ti promette.»
Ma la verità si svela presto:
«sei entrato in una tana, nella grotta di un ladrone. …Per prima cosa ti riscalda gli avanzi della cena precedente e giura e …sacramenta che ha appena finito di cucinarla. Tutto ha sapore di rancido, tutto sa di fumo e di tizzone. Ahimè che cosa sei costretto mai a tracannare… L’ostessa che lava il marmocchio e gli forbisce il culo con le mani e poi ti prepara le carni che ti accingi a mangiare. “Oste – tu gridi, – oste, non mi senti? Dimmi, oste, com’è che questo vino è così acido? Dove sei andato a trovarlo? Dov’è quel vino che mi avevi promesso poco fa, il Corso, il Mangiaguerra, il Sanseverino, il Greco, quella divina bevanda?” E quello o è diventato sordo all’improvviso, oppure se ti risponde, è tanto bravo di combinare le sue fanfaluche che vuole che tu ammetta esattamente il contrario, e cioè che la muffa marcia di vascello non è che miele e zucchero.»
[Baldus, lib. XI, 585-623, op. cit.]
Altrove, rievocando il saccheggio da parte di milizie mercenarie del monastero in cui era ospitato, il Folengo descrive il suo sincero dolore di capocantiniere e bevitore per tanto spreco e devastazione:
«dalle cantine infine hanno spinato fuori la nostra vita: si bevono il vino, quei porci, e poi spaccano i barili e fanno fare il bagno ai cavalli nella vernaccia.»
[Baldus, lib. X, 179-181, op. cit.]

Infine, lascio alla rustica e parodistica descrizione dell’Autunno, con cui viene facile evocare la celebre pittura dell’Arcimboldo, il compito di invogliarvi alla riscoperta di questo autore ingiustamente trascurato, così prezioso per la comprensione delle usanze cinquecentesche in fatto di cibo e bevande: ovviamente ne gusterete di più il sapore leggendola in originale, ma la traduzione può darvene un’idea.
«Gli antichi solevano dare all’Autunno il nome di Sileno e dicevano che la sua testa calva era stata pizzicata dai tafani. Egli sopraintende alle case di Bacco e a tutti i suoi famigli: noi lo diremmo il suo gastaldo, o come molti preferiscono, il suo fattore. Poiché il Sole gusta volentieri il vino dolce, e infatti la mattina lo vediamo sempre carico di mosto, è un grande amico del gastaldo di Bacco e di Bacco medesimo. Questo Sileno ha per moglie una ninfa che ha la testa grossa come un otre e la pancia che pare una tinozza. Odora sempre di vino, e si chiama, insomma, la Vendemmia».
[Baldus, lib. XIV, 261-270, op. cit.]





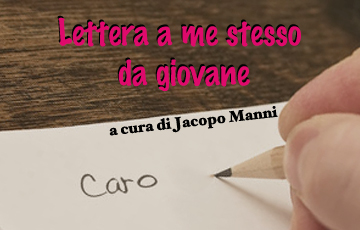






2 Commenti
Sir. P
circa 8 anni fa - LinkBello bello bello. Bravo Thomas.
RispondiThomas Pennazzi
circa 8 anni fa - LinkThank you, dear Sir !
Rispondi