I vini di Montello e Asolo al gusto degli antichi. Parte prima
di Pietro StaraSe c’è un filo rosso che segna implacabilmente la storia dell’Italia dei comuni, sino al più recente processo di unificazione, è quello legato all’imposizione fiscale e ai conseguenti tentativi di svicolare da essa. Le ragioni furono, come si può ben immaginare, sia da una parte che dall’altra, molte e di diversa natura: alcune nobili, altre molto meno; alcune atte a consolidare poteri e onori, altre, ancora, dei mezzi di mera sussistenza.
La storia del fisco parla, e nemmeno troppo in fondo, delle formazioni del potere, del loro consolidamento, della ridistribuzione delle ricchezze e dell’appropriazione di quest’ultime, lecite o meno che siano state, giuste o meno che le si racconti. E come spesso capita, parlando di una cosa, si fa riferimento a tutt’altro. Così, nel Trevigiano, tra Tre e Quattrocento, tutto il vino prodotto doveva essere soggetto ad una tassa pagata in soldi e in lire di piccoli, mentre i sudditi del centro e del sud Italia erano tenuti a scucirli in ducati d’oro: delle commissioni, formate da un cittadino, da un notaio e da un banditore del comune, venivano insediate perché l’incarico esattoriale fosse portato a termine.
Ogni commissione aveva giurisdizione su di una parte del territorio trevigiano: i giurati delle città e delle comunità dovevano quindi fornire i dati relativi al vino prodotto agli ufficiali incaricati della registrazione. I dazieri del vino al minuto dovevano controllare che i sigilli apposti sul fondo e sul cocchiume delle botti non venissero rimossi. Le misure utilizzate per lo spaccio del vino erano le mezze fogliette (Foglietta = 0.508607 Lt) e quarti di foglietta in vetro per i vini pregiati (cretesi e moscatelli tra tutti), mentre foglietta e mezza foglietta venivano usate per i vini comuni (nostrani, le ribolle e i vini marchigiani).
Due erano le macro tipologie di un vino: quello di prima scelta e quello si seconda chiamato anche primaqua, probabilmente in riferimento ad una prima, e acquosa, torchiatura. Gli ufficiali giravano non soltanto le osterie, ma anche le singole famiglie che erano in obbligo di denunciare il numero delle bocche (omnes buchas) della famiglia da un anno in su: da questo si può pensare che non vi fossero restrizioni rilevanti al’uso del vino in età infantile. Poi si faceva di conto: la tassa era calcolata sul vino bevuto dal momento della vinificazione sino alla prima ispezione, decurtato di mezzo bigoncio (antica misura di capacità per liquidi, usata a Venezia fino al 1866, equivalente a litri 150,2340) al mese per ogni bocca.
La decurtazione sarebbe dovuta servire come incentivante alla fornitura di dati veritieri: una sorta di rientro dei capitali in salsa medievale rivolta perlopiù a gente povera se non poverissima. Ma nulla da fare: come ricorda una lettera inviata dal podestà di Treviso, Donato Moro, datata 11 novembre 1393, ad Andrea Zane, podestà di Castelfranco, nonostante lo zelo dei funzionari governativi, i contadini nascondevano dovunque (siepi, fratte, boscaglia, cespugli) il loro vino. Di qui una pensata che ricorre in vari momenti della modernità più recente: la delazione sotto copertura del nome. Non è dato sapere quanta tassazione sia stata recuperata e ancor meno quante vendette personali si siano consumate negli anfratti di quei boschi che ospitavano cospicue carrate di vino.
Da tutte quelle trafile finanziarie, infine, siamo giunti a sapere che i vini di “Montelli et Montisbelluni et eorum districtum sunt meliora vina aliis vinis Trevisane“[1]. Insomma, nell’Asolano si facevano vini più buoni che in tutte le altre parti del trevigiano e per tale ragione i serenissimi decisero di tassarli un terzo in più (circa) rispetto agli altri: 36 soldi per carro di vino (due botti per vino costituivano un carro; ogni botte era della capacità di 28,556 palmi cubici pari a 0,52346 metri cubi = 523,460 decimetri cubi = 523,46 litri), invece degli usuali 26. Non sappiamo però, ancora oggi, a quali uve si facesse riferimento. D’altra parte, anche le più antiche fonti statutarie fanno riaffiorare in maniera non sistematica le diverse tipologie di allevamento della vite nel basso medioevo veneto: viti coltivate basse in colina ed alte in pianura, spesso maritate ad alberi come aceri, olmi e salici. Ma non mancano riferimenti a viti sposate a frassini, olivi e, nelle terre asolane, anche ai ciliegi[2].
Non soltanto il vino poteva prendere strade tortuose e inaspettate, tanto da richiedere la regolamentazione di quei mestieri legati al trasporto e allo scarico del vettovagliamento, con l’apposita creazione di scuole per bigonciai, con l’obbligo di versamento di 10 lire a garanzia della qualità del lavoro prestato (Bassano del Grappa) e con la strutturazione delle corporazioni di mestiere: l’uva stessa era oggetto di attenzione precipuo delle autorità comunali e la vendemmia lo snodo fondamentale. La definizione di un data da cui far partire la vendemmia serviva a tutelare sia l’impresa privata che la comunità da un’immissione anticipata delle uve nel mercato cittadino. Lo stessa valenza tutelante risiedeva nell’obbligo di ammostare immediatamente l’uva raccolta. Ogni comunità decideva, in concomitanza con una festa patronale riconosciuta, l’inizio della raccolta dell’uva e le punizioni legate alla violazione della stessa: nel Trevigiano era la data del 14 settembre, festa della S. Croce, sotto ordine esplicito del podestà, che segnava l’inizio della vendemmia.
Dopo un periodo di relativa quiete, la Marca Trevigiana venne sconquassata in lungo e in largo dalla lunghissima e durissima guerra con la Lega dei Cambrai: nonostante ciò, messere Giovanni Bonifaccio, nella sua “Istoria di Trivigi” del 1591, così scrisse: “I terreni pani producono ottimo grano, e vino buonissimo; ed il migliore è quello della riviera del Montello, de’ colli di Montebelluna e della Valdobbiadene; e quasi la metà basta al paese; l’altro è condotto per lo più a Vinegia.” Vini buoni, migliori di quelli prodotti in altre zone, a volte buonissimi: ma di quali vini e di quali uve stavano parlando? Andrea Bacci, nella sua monumentale De naturali vinorum historia (Roma 1596), parlò genericamente di Vernacce piuttosto asprette e gradevoli per il sapore sugoso: “ne trae però un’abbondante produzione di dolci dal vicino paese di Montebelluna.” (secondo capitolo del libro VI).
Ma ancora nessuna varietà esplicitata: bisognerà aspettare qualche tempo, poco più di 80 anni (Cento e dieci ricordi che formano il buon fattor di villa, 1679), perché Giacomo Agostinetti di Cimadolmo, dopo aver sudato come fattore ne’ campi, alla veneranda età di 82 anni, desse conto di alcuni vitigni coltivati nel Trevigiano. Agostinetti raccontava (Ricordo XXIV) che dalle sue parti si facevano i vini neri per Venezia, tra i quali spiccava la ‘Recandina’, che altri chiamavano rabora[3], molto prolifica e da cui si faceva un vino buono e bello e “il suo vero modo di essercitarla è il vendemmiar come si costuma nelle brente empite co’ cesti” per poi buttarla nel Tinazzo, che “se ne rompe qualche poca” e poi si scalda con quel poco di mosto che “dà fomento al farla riscaldar”. Poi una “follazata” alla sera e alla mattina seguente e ancora per sei giorni perché si rompa solo un po’ dell’uva nuova aggiunta nel Tinazzo: “acciò sempre si rompi qualche poca di uva nuova, acciò mosto uscito non pigli la graspa, che stando cosí bolente sotto l’uva, con il frequente follazar ogni volta si rinova il mosto nel Tinazzo, il scorzo dell’uva infracidisse, dal qual scorzo s’attende il nero.” Lo scorzo, la buccia, raccontava Agostinelli era nerissimo come l’inchiostro, da cui s’attendeva che fosse quello, e non altro, a consegnare il cupo colore al vino. Poi si faceva bollire quell’uva così condensata per altri otto o dieci giorni e finita la fermentazione entravano i contadini, “co’ loro pedacci”, per spremerla sino alla fine, facendo rendere tutto il nero possibile.
Verso la fine del ‘700 fu Domenico Zambenedetti[4], nella sua memoria presentata all’Accademia Agraria degli Aspiranti di Conegliano, a distinguere la Recaldina dalla Rabosa, consigliando di impiantare la prima sulle colline. Ma non è ancora chiaro a quale uva si faccia riferimento tanto che nel 1868, nella Ampelografia generale della provincia di Treviso (1868), si riporta la netta distinzione fra varietà Rabosa nostrana, Rabosa veronese e Recaldina nera e si ipotizza per quest’ultima una possibile sinonimia con la “Friulana” (Raboso Piave) del Padovano e con la Bassanese.
Si afferma, inoltre, che il vino ottenuto dalle uve di questa varietà “si chiarifica con facilità e scarseggia di materia colorante”. Questa notizia rimanderebbe ad una versione completamente diversa da quella presentata da Agostinetti sulla potente capacità colorante dell’uva Recandina.
Da un’ indagine successiva condotta da Vianello e Carpenè, pubblicata nel 1874, la Recandina risultava tra le uve rosse più coltivate in 3 Comuni del distretto di Treviso, 2 nel distretto di Asolo e 2 nel distretto di Castelfranco, per un totale di 28.815 hl di vino.
Oggi si parla di tre tipologie di Recantina. Due molto simili per grappolo e foglie sono quelle isolate a Fonte Alto: la Recantina a pecolo o peccolo scuro e la Recantina a pecolo rosso. A Castelcucco , invece, la Recantina denominata “Forner”, dal nome della azienda, si distingue dalle precedenti. Nell’asolano le recantine si presentano abbastanza simili alle prime due, e soprattutto alla Recantina dal pecolo rosso.
E infine, per tornare a Cosimo Agostinetti e alla fine del 1600, le altre uve nere: i Marzemini e le Schiave nere. Ma il vino migliore, dolce ovvero non aspro, lo si faceva con l’uva ben matura della Bianchetta gentile piantata sulle colline. Altre uve bianche costellavano il panorama viticolo di Montello e de’ colli Asolani: la Schiava bianca, la Marzemina bianca, la Pignola, buona da mangiare e da vinificare, “da levare li primi di settembre”. A fine mese si vendemmiavano la Lustra, la Cornarola, la Cellina e la Grossara. A fine ottobre le uve “garbe di natura”: la Rabosina, la Rabosazza e la Cincinosa.
[1] Cfr. Antonio Calò, Lamberto Paronetto, Giampiero Rorato, Storia regionale delle vite e del vino i Italia, VENETO, Accademia Italiana della vite e del vino, Centro di cultura e civiltà contadina – Biblioteca internazionale “la Vigna” – Vicenza, Edizioni Unione Italiana Vini, Milano 1996
[2] G. Cagnin, Il castagno nel paesaggio agrario e nell’economia a Treviso nel medioevo, in “Studi Trevisani”, 8, 1997 citato da Ermanno Orlando, Coltura vitivinicola, consumo e commercio del vino: il contributo degli statuti comunali veneti, in La vite e il vino, Storia e diritto (secoli XI – XIX), Volume I, Carocci, Roma 2000, pag. 85
[3] Alcuni testi storici parlano di rabosa, ma nel testo che ho consultato, stampato in Venezia, per Francesco Tramontini, nel MDCXCII, l’autore la scrive con “r”
[4] Cfr. G. Zoccoletto, L’Accademia Agraria degli Aspiranti di Conegliano, Ed. Unione ex Allievi Scuola Enologica, Conegliano 2001





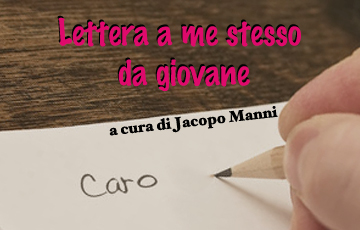






1 Commento
carolaincats
circa 9 anni fa - LinkAgostinetti letto e riletto millemila volte per fare la tesi sul Raboso. una bella lettura caro Piero, grazie!!
Rispondi